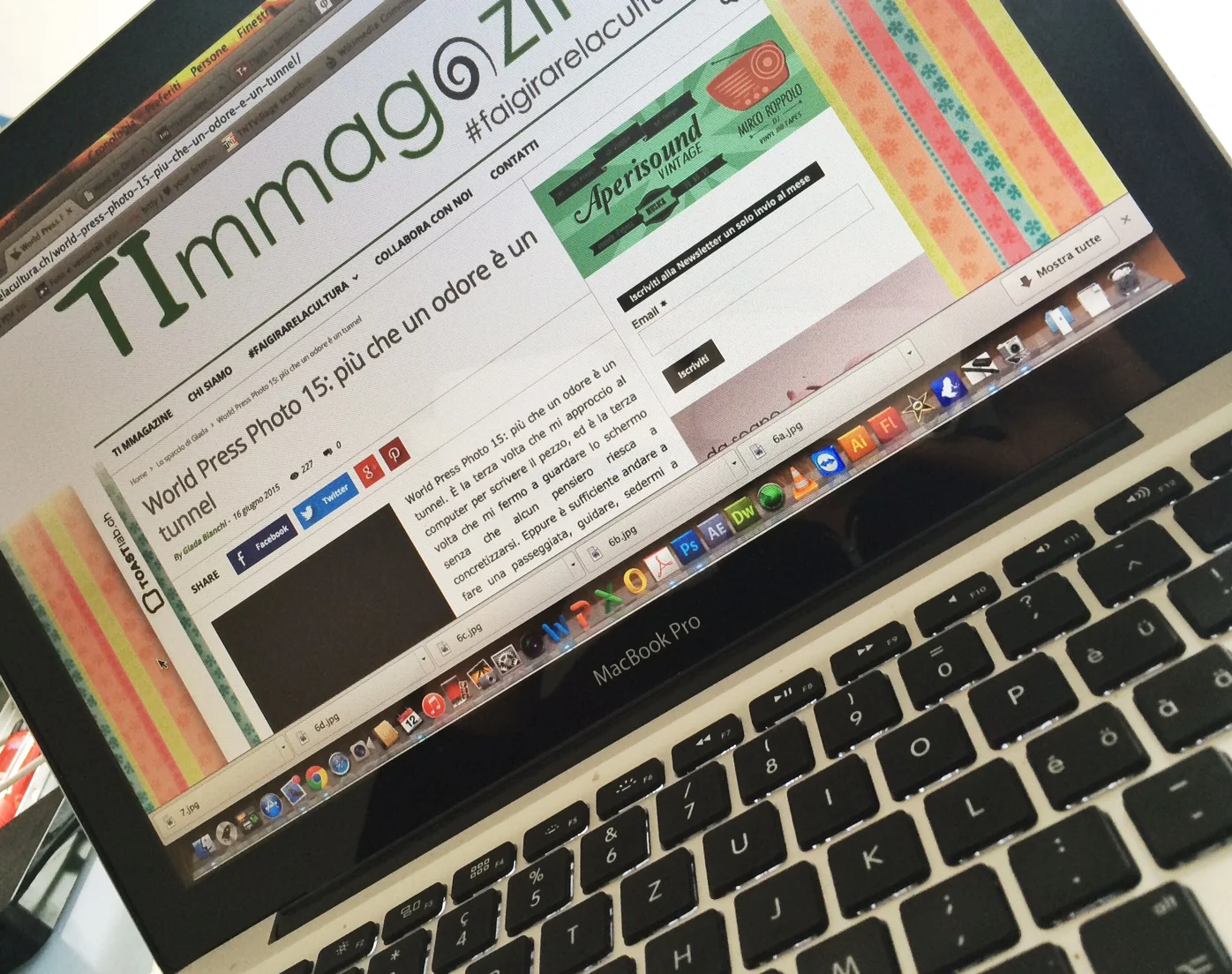Ho scelto di tramutare in opera artistica questo progetto perché credo molto nella trasformazione dell’ordinario in meraviglia: un’alchimia necessaria affinché la magia possa tornare a circolare nel quotidiano, rendendo ogni giorno non solo un fatto scontato ma soprattutto un’esperienza unica che val sempre la pena vivere.
Gli alberi. Grandi, possenti, vivi, detentori di segreti e veri e propri orologi del tempo che passa, poi ritorna, e infine se ne va. Il Teatro dei Fauni di Locarno ha deciso di tramutare in esperienza collettiva il tesoro racchiuso in questi esseri attraverso il progetto “Antenati con le radici”. Durante gli incontri, gratuiti e aperti a tutti, gli interessati si ritrovano ai piedi di un albero centenario della città per sentirne raccontare la storia, la provenienza, aneddoti, segreti e proprietà, il tutto accompagnato da un’azione scenica di teatro, danza e/o musica. Ai presenti viene inoltre consegnato un dossier contenente quanto udito, in modo che il prezioso sapere possa venir condiviso con altri: piccoli semi di rispetto e curiosità pronti a germogliare nelle coscienze altrui.
Da questa idea è nato il dipinto, in acrilico dim. cm ca. 40x55, su cui ho inoltre riportato un testo di Hermann Hessedel 1919 tratto da “Alberi”, che mi sembrava coerente con il messaggio dato dalla performance:
“Gli alberi sono santuari. Chi sa parlare con loro, chi li sa ascoltare, conosce la verità. Essi non predicano dottrine e precetti, predicano, incuranti del singolo, la legge primigenia della vita. Gli alberi hanno pensieri duraturi, di lungo respiro, tranquilli, come hanno una vita più lunga della nostra. Sono più saggi di noi finché non li ascoltiamo. Ma quando abbiamo imparato ad ascoltare gli alberi, allora proprio la brevità, la rapidità e la precipitazione infantile dei nostri pensieri acquistano una letizia incomparabile. Chi ha imparato ad ascoltare gli alberi, non desidera più essere un albero. Non desidera essere altro che quello che è. Questa è la patria. Questa è la felicità”.
Il presente lavoro è stato concepito come premio per l’edizione di #faigirarelacultura del 2016. Per partecipare all’edizione del 2017 clicca qui: potrai vincere, oltre a numerosissime opportunità e premi, una personale elaborazione fotografica del tuo progetto.
Nella fotografia la consegna del premio a Santuzza Oberholzer del Teatro dei Fauni di Locarno, attraverso la persona di Roberta Nicolò.